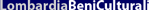Introduzione
Sono qui editi i due documenti superstiti dell’archivio del capitolo della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Bormio [1].
Il primo, risalente probabilmente al 1139, lega la storia di questa istituzione capitolare con le vicende occorse
alla chiesa di San Siro di Bianzone
(si vedano anche Le carte della chiesa di San Siro di Bianzone tra i fondi minori valtellinesi).
Si tratta della celebre donazione che di quella chiesa, sita nella media Valtellina, fecero le sorelle Naluzia e Pagana ‘de
Turre’, insieme ai loro sposi, a favore dell’arciprete Giovanni e dei canonici del capitolo dei Santi Gervasio e Protasio
di Bormio.
Questa donazione, edita al numero 1, è oggi conservata in copia autentica presso l’archivio
della parrocchia di Bianzone; si tratta di una copia seicentesca derivata a sua volta da una precedente copia autentica cinquecentesca
avente come antigrafo l’originale conservato presso il tabularium del suddetto capitolo bormino, come illustrato in
dettaglio nel testo introduttivo a quel documento.
L’originale, presso quell’archivio capitolare, oggi risulta perduto da almeno tre secoli [2].
Invece, vi è ancora conservato –seppur mutilo– un cartulario del 1402, che di questa donazione riporta un ampio regesto.
E pure all’interno del cartulario del 1402 è conservata la memoria del documento qui edito al numero 2, e risalente al 1196.
Riguardo a tale cartulario pare necessario fornire qualche dato in pi˘, utile per meglio contestualizzare questa
fonte preziosa per la conoscenza delle rare testimonianze relative all'epoca qui indagata.
Siamo a conoscenza della sua intitolazione, oggi caduta, grazie alla descrizione che ne fece Ignazio Bardea,
autore nel 1766 delle Memorie storiche per servire alla storia ecclesiastica del contado
di Bormio [3].
Egli aveva potuto consultare quella fonte quando era ancora integra:
«Esta tal libro nell’archivio del capitolo, scritto è in pergamena ed ha per titolo quanto segue: ‘In nomine Domini anno .MCCCCII. die madii. Iste est liber seu quaternus omnium testamentorum iudicatorum capitulo eccelsię Sanctorum Gervasii et Protasii de Burmio Cumanę dięcesi, traditus et imbreviatus per notarios in dictis capitulis contentos, que quidem testamenta sunt extracta de quaternis dominorum notariorum antiquorum et novorum per me presbiterum Iohannem de Capitaneis de Figino archipresbiteri dictę eccelsię de Burmio et scripta manu sua et etiam in calendario antescripto posita in modum sequentem» [4].
Promotore della redazione del liber –come appare dall’intitolazione citata e come confermato
dall’analisi della cronologia dei documenti– era stato l’arciprete Giovanni Capitanei de
Figino [5].
Egli aveva voluto il liber omnium testamentorum al fine di tutelare gli interessi del capitolo nel
contesto dei conflitti che –negli anni a cavallo dei secoli XIV e XV– contrapponevano i canonici
all’autorità comunale del borgo, che avanzava pretese per l’amministrazione laicale delle
rendite ecclesiastiche [6].
La intestazione succitata contribuisce pure a fare chiarezza circa la struttura unitaria del cartulario, che
è ben attestata anche da un punto di vista codicologico [7].
Esso, ab origine, fu articolato in due parti distinte e complementari, raccordate da un ricco apparato
di rimandi [8].
In apertura vi si trova un calendario–stazionario, sul quale sono annotati gli obblighi del capitolo
[9].
Questa sezione occupava tre sesterni (tuttavia già nel Settecento il primo fascicolo era interamente
deperdito, mentre attualmente l’ultima carta del terzo fascicolo risulta tagliata).
Occupava un sesterno anche la seconda sezione del liber, che riunisce i regesti dei testamenti,
delle donazioni inter vivos, dei legati (…) a favore del capitolo di Bormio.
Oggi tale sezione si presenta mutila del primo foglio.
Le 11 carte disponibili contengono 72 regesti di documenti, dei quali 2 sono anteriori al XII secolo
(quelli qui presentati), 8 sono risalenti al XIII, 51 al XIV e 11 al XV secolo.
Note
[1] La più antiche menzioni alla chiesa di Bormio si troverebbe all’interno di un diploma lotariano a favore della Chiesa di Como. Si tratta del discusso precetto in data 3 gennaio 824, Compiègne. Trasmesso soltanto dal cartulario della Chiesa di Como (del sec. XIV e attualmente conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano), poi ripreso in copie successive, è certamente interpolato: edizione in MGH, Diplomata, Die Urkunden der Karolinger: Lothars I (822–855), n. 3, pp. 54–59. Non è questo il contesto per affrontare le spinose questioni circa l’autenticità del documento; in questa sede e con stretta attinenza al tema indagato, mi limito a rimandare a BESTA, Bormio antica e medievale, pp. 24–25 e a CELLI, Longevità, p. 49 e bibliografia ivi citata.
[2] L’archivio del capitolo sin dal Settecento era fortemente depauperato, come già Francesco Saverio Quadrio nelle sue settecentesche Dissertazioni storiche, II, p. 457, annotava: «I documenti, parte per le vicende de‘ tempi e parte per gl’incendi e per le guerre smarriti, ci tolgono le ulteriori notizie».
[3] Oggi conservate manoscritte presso l’archivio del comune del borgo.
[4] BARDEA, Memorie storiche, I, pp. 186–187. L’intestazione era stata parzialmente copiata anche da QUADRIO, Dissertazioni storiche, II, p. 457n.
[5] Così il Bardea descrive il de Figino: « Era in questo tempo arciprete di Bormio Giovanni de Capitanei di Figino uomo distinto e qualificato non solo della dignità di cappellano della Santa Sede, ma ancora di quella díarcidiacono della cattedrale di Como come appare da uno istrumento dell’anno 1413 (leggesi in uno istrumento in cui viene registrato un legato di lire 26 imperiali da impiegarsi in un fondo (…) fu rogato da Giovanni di Benvenuto de Bonizzi» (BARDEA, Memorie historiche, I, pp. 186–187). Riguardo all’iniziativa di questo arciprete lo stesso autore annotò: «ebbe questo arciprete tutto l’impegno a vantaggio della collegiata de’ Santi Gervasio e Protasio a servigio della quale da quaderni di diversi notai raccolse i legati al capitolo fatti e ne formò di tutti quel libro che più volte citammo e che avremo occasione di citare frequentemente, perochè anche i successori arcipreti altri legati vi registrarono da’ quali ricavare si possono curiose memorie» (BARDEA, ivi, p. 186).
[6] A questo proposito: SILVESTRI, Lettere del capitolo di Bormio, pp. 7–44, (pp. 7–18, 40–42) e CANOBBIO, Visita pastorale, pp. 56–57, pp. 177–178.
[7] Ciò in relazione al regolare numero di carte che li compongono, alle identiche dimensioni, alla presenza di un’unica mano di scrittura, alla cartulazione progressiva e continua, alle modalità costanti di rigatura e marginatura a inchiostro, alla regolarità dell’affrontamento carne–carne pelo–pelo.
[8] La coerenza progettuale del liber è attestata soprattutto dalla costanza dei rimandi dal calendario alla corrispondente carta ove si trovava il regesto del documento fondativo dell’onere. Ad esempio, al verso della prima carta attualmente conservata, in corrispondenza dell’8 di maggio, festa Victoris martriris, aparitio sancti Michaelis arcangeli, si legge: «<Annuale> Dominice Morese de Burmio cum Iohanne viro suo statuerunt molinum sub Sancto Vitale: in folio .xliiii.». Il rimando è alla carta ove è copiato il regesto qui edita al numero 2.
[9] Mutilo, inizia dal 30 aprile, con la festa di san Quirino martire. Presenta la successione dei giorni, accompagnata dal titolo dei giorni festivi, dal nome del o dei santi e dall’indicazione della luna (componente necessaria per questo tipo di fonte). Accanto alla memoria degli anniversari e dei doveri di messa da osservarsi dal capitolo in precisi giorni in base ad un testamento o ad un legato istituito a favore dell’ente stesso, viene segnalata anche la memoria della dedicazione o della consacrazione delle chiese site in Bormio e nelle località limitrofe (purtroppo, però, senza indicazione dell’anno dell’evento fondativo e del nome del prelato che svolse il rito). Il calendario mostra una stratificazione di grafie. Vi si riconosce la mano ‘primitiva’, quella del 1402, che scrive le date, i nomi dei santi e le più antiche memorie di anniversari, sempre seguite da un rimando ai foliis che attestano e documentano i singoli diritti capitolari. È evidente l’apporto di mani ovviamente successive finalizzate all’aggiornamento del calendario: esse annotano gli oneri anniversari che si andavano aggiungendo a quelli più antichi, in virtù di lasciti recenti. Questo intervento di numerose mani si riconosce sino alla metà del XVI secolo. A quest’epoca, e più precisamente nel 1584, venne compilato un nuovo calendario, che si rendeva certamente necessario sia per la confusione che si era progressivamente generata a causa dello stratificarsi di annotazioni, sia anche –e forse soprattutto– a motivo delle novità introdotte dalla riforma del calendario annesso alla editio typica del Breviarium Romanum di Pio V (1568) il quale a sua volta venne adattato alle esigenze della riforma liturgica propria di Como, sfociata nella stampa del Breviarium Patrirchinum (Comi, Apud Hieronymum Frovam, 1585).